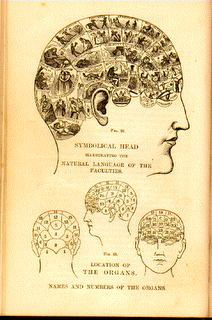Quando le prime voci si diffusero a Su Mortoriu dicevano che la miniera d’argento era crollata e che al posto della piana adesso c’era qualcosa come il cratere di un enorme vulcano.
Ines era sveglia, non aveva chiuso occhio e nel suo modo riservato fremeva e aspettava che il vento le portasse notizie di quel figlio che non era ancora tornato.
Quando i Parris, dalla finestra, vedendola sveglia a quell’ora improbabile le dissero che era crollata una parte della piana lei non perse altro tempo.
Si fece il segno della croce e stese uno scialle nero sulle spalle per correre fuori. Cercò Donna Aurelia per chiederle il cavallo in prestito, dato che Astor e suo nipote Alvino se ne erano andati con il carro, ma non trovò nessuno in quella grotta che fungeva da abitazione. E nessuno d’altra parte l’aveva vista da molte ore.
In pochi minuti si erano svegliati tutti in quel borgo e ci si preparava ad andare a vedere lo spettacolo terrificante di quel cratere immenso.
Salì sul primo convoglio, con la gente che andava a vedere e prestare i primi eventuali soccorsi.
Suo figlio Astor era partito per andare in città con il carro e con i corpi dei due bracconieri colpiti a morte, ore prima.
Questo fatto e la cattiva notizia della piana che era sprofondata non promettevano niente di buono.
Astor, lei avrebbe voluto che non si mettesse nei guai, ma sapeva benissimo come lui la pensava. “sono i guai che cercano noi, mamma, non il contrario”. Così le diceva sempre suo figlio con un certo orgoglio.
Quel figlio aveva ereditato da suo padre anche un’altra teoria: “è attraverso le difficoltà che capisci quanto vali e con quale passo si affronta la grande danza della vita”.
Ed era con quella teoria che lei era rimasta vedova e non si rassegnava, adesso, a diventare orfana di figlio. Perché di solitudine e miseria nera ne aveva abbastanza.
Lui era cresciuto nei vicoli e nei pascoli della piana piuttosto che a scuola con un maestro. E forse proprio per questo motivo la vita piatta e da salotto non aveva mai sfiorato, come idea, neppure nel libro dei desideri.
D’altra parte chi nasceva da quelle parti era difficilmente sensibile a certe eventualità.
Sembrava che le piste percorse dalla buona sorte avessero dimenticato completamente quelle latidudini lasciandole a seccare sotto il sole torrido, che d’altronde faceva benissimo alle coltivazioni di Banane Majestic e cacao e caffé.
Quando comparve sulla collina sovrastante la piana, Don Enrico il senatore, a cavallo del suo mustang bianco importato dal Texas, in compagnia dei suoi scagnozzi e guardie del corpo, non credette ai suoi occhi.
“Per la malora Luisito, hai mai visto niente del genere?”
“Nossignore; sembra che se la sia inghiottita l’inferno, questa dannata piana do diablo”
Presero a ridere nella maniera sguaiata tipica loro. Ed erano decine, tra guardie del corpo e semplici caporali, che scortavano il potente latifondista; tutti venuti di corsa dai bananeti circorstanti per godersi lo spettacolo.
“guarda con il binocolo, ma quello non è un corpo umano?
“ Si, sì, guarda lì di fianco, ne escono degli altri”
Rimasero a schiamazzare con rinnovato vigore quando si resero conto che da quella mota fuoriuscivano degli uomini.
E se avvenne che qualcuno, ingenuamente, si ponesse l’interrogativo se non era il caso di avvertire l’autorità per prestare soccorso, per poco non fu linciato e trattato da guastafeste.
“ma guarda, chi sono quelli abitanti delle caverne?
“Da dove diamine spuntano?”
“e allora che il diavolo se li porti, se vogliono vivere sottoterra che ci restino.
Ha ha ha “
“Passami la borraccia, Fefé, che questo fango mi ha messo sete”.
In quel momento il latifondista e gli sgherri inquadrarono un carro che arrivava a una certa velocità ignaro di quello che era accaduto. Si spanciarono dalle risa quando videro quel carro inghiottito dal fango con il suo carico. Il duca di porcellana e i chicos furono ricoperti e inghiottiti letteralmente da quella melma terribile. Elmer risvegliatosi all’improvviso dalla sua furia si muoveva furtivo. Il suo istinto gli diceva che il pericolo era vicinissimo.
Lasciò cadere il corpo di Astor. Lui si finse svenuto.
Elmer si alzò in piedi e si tastò nel petto, meccanicamente, cercando il taccuino nero dei picocca. Guardava lontano ma l’alba non era sorta completamente e la visibilità non era totale.
Cercava di scrutare, aveva vist benissimo, un carro con i chicos e il duca di porcellana che erano arrivati in velocità.
Poi erano spariti nella frana di fango.
Non era sereno.
Cercare. Cercare ancora.
Questo gli diceva il suo istinto.
Si portò verso il carro rovesciato di Astor che stava scomparendo anche questo, immerso nel fango. Non ne abbe paura, si sentiva protetto da quello strano destino di ribelle.
Si inoltrava nel fango, adesso, a cercare quel libro che, non sapeva perché, ma per lui valeva più della sua vita.
Affondava Elmer. E quel fango era perfino più schifoso e umido di quanto non avesse immaginato.
Gli copriva il viso, fin sotto il mento. Poi la bocca. Poi eccolo!
Sembrò di scorgere qualcosa che poteva essere il suo libro nero e mentre finalmente si faceva in avanti per prenderlo qualcosa lo afferrò per la caviglia e lo portò a fondo.